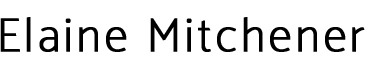Il Manifesto – 6 January 2019
Elaine Mitchener e il suono della paura
Marcello Lorrai
An interview in Italian with national newspapaer Il Manifesto about Elaine Mitchener’s latest project SWEET TOOTH.
Musica. Dalla classica al jazz passando alla contemporanea, è il lungo percorso dell’eclettica artista londinese. Il suo progetto – «Sweet Tooth», racconta i drammi del sistema della schiavitù e della tortura. «Ho registrato l’esperienza di milioni di persone: la privazione della libertà, la vendita all’asta, la lavorazione della canna per produrre zucchero»

Elaine Mitchener è una giovane vocalist britannica i cui interessi spaziano dal jazz alla musica contemporanea, dall’improvvisazione alla performance, dal movimento alla danza. Ha in repertorio i Song Books di John Cage. Ha interpretato Manga Scroll di Christian Marclay, oggi forse più conosciuto nell’ambito dell’arte contemporanea che della musica, e lavori del compositore sperimentale Alvin Lucier e di Ben Patterson, uno dei protagonisti di Fluxus. Il suo Sweet Tooth, che ha avuto la sua prima londinese nel febbraio 2018, è una vibrante riflessione in chiave di teatro musicale sulla schiavitù a partire dalle sue origini giamaicane. Ha allestito un programma di Vocal Classics of the Black Avant-Garde, con brani di Jenne Lee, Archie Shepp, Joseph Jarman, Eric Dolphy (lo riproporrà domani a Londra al Café Oto). Sta preparando un omaggio a Jeanne Lee, la più grande vocalist del free (prima il 14 giugno nella capitale britannica, al Kings Place). E con il pianista Alexander Hawkins, uno dei più brillanti e dinamici protagonisti della giovane generazione dell’improvvisazione europea, ha inciso in quartetto UpRoot (Intakt, 2017) intestato ad entrambi. Lo scorso settembre è stata ospite in Sardegna per il festival Ai confini del jazz, sua prima esibizione italiana.
Come ha iniziato a cantare?
Sono nata a Londra, i miei genitori sono giamaicani. Ho cominciato a cantare in chiesa, gospel, ho fatto parte di un gruppo vocale di ragazze: in questo senso il mio è stato un percorso molto tradizionale. Poi ho studiato canto al Trinity College of Music e ho preso lì il mio diploma, poi ho continuato alla Goldsmiths University. Ammiravo il canto classico, l’ho studiato alla Trinity, e ho imparato a cantare in italiano, francese, tedesco: arie, brani del repertorio tradizionale e la base di quella tecnica è veramente importante per quello che faccio adesso. Mi piace andare alle opere, mi piace sentire le cantanti, le ammiro e sono una grossa ispirazione, ma ho capito presto che non avrei voluto avere una carriera da cantante classica tradizionale perché i miei interessi sono più ampi.
Cosa le mancava?
Se da giovane hai cantato gospel in chiesa, ti sei trovata a dover eseguire delle canzoni all’ultimo momento, giusto il tempo di capire il titolo e di sperare che il pianista o l’organista la suoni in una chiave in cui puoi cantarla: e, semplicemente, lo fai. E quando hai imparato a farlo da molto giovane hai imparato ad improvvisare, e a farlo senza avere paura, ed è una cosa che ti piace oltre che un allenamento eccezionale per una attività come musicista professionista. Ho anche imparato che le canzoni aiutano le persone a guardare a se stessi, e a prendere delle decisioni importanti: una canzone può cambiarti la vita. Questo me lo ha insegnato la chiesa, non il music college. Dopo ho trovato veramente difficile sentire in questa prospettiva le arie di Mozart o di Puccini: io conosco il senso di questi brani che musicalmente sono meravigliosi, ma sono qualcosa che non è per me esperienza reale. Il music college ha un po’ ucciso il mio amore per il canto, e ne sono uscita non molto convinta.
E come è arrivata poi all’attività professionale?
Ho fatto altre cose, cantavo un po’ ma avevo paura di farla diventare una carriera, perché è dura. Cantare come lavoro mi spaventava, avevo degli amici che lo facevano e vedevo che lotta era. Hai un’ora di gioia e dopo ti dici: quando sarà la prossima performance? Quando entreranno altri soldi? Lavoravo per la Ricordi come promotion manager, promuovevo compositori a Londra, e ho appreso molto sul business della musica classica, un impiego decisamente interessante. È successo che qualcuno dei miei clienti ha scoperto che cantavo e mi hanno chiesto di farlo nei lavori dei compositori che cercavano di far eseguire. Mi hanno incoraggiata. In definitiva ero una performer: la porta si era aperta. E così ho cambiato lavoro.
Quando è entrata in contatto con la scena improvvisativa?
Avevo quattordici-quindici anni e il mio insegnante di flauto a scuola era un improvvisatore free, Neil Metcalfe. Siamo diventati amici, io ero troppo piccola per andare ai concerti, ma lui è stato il mio primo contatto con questa scena. Poi ho cominciato ad entrare in questo ambito con il mio ex marito, pianista: oltre che con Neil ho lavorato molto con Steve Beresford, Evan Parker, Mark Sanders, John Butcher, David Toop, e sono stata guest con la London Improvisers Orchestra. Amo molto lavorare con un vocalist come Phil Minton. È una scena ricca con improvvisatori di talento.
Un recensore ha scritto che grazie all’intensità della sua interpretazione, ha fatto tremare le pietre della chiesa di Londra in cui ha presentato «Sweet Tooth»
Mio padre è morto cinque anni fa e pensavo a cosa avevamo in comune, per esempio amavamo lo zucchero. E ho cominciato a ragionare sulle varie implicazioni dello zucchero, a come può fare male alla salute, a come viene prodotto e, rispetto al passato, al fatto che era una merce molto costosa. Ma anche al costo umano necessario per fornire questo bene in paesi lontani dal luogo da cui lo zucchero proveniva. Ho lavorato con uno storico: mi affascinava come il sistema della schiavitù potesse stare in piedi ed era solo attraverso la paura e la disumanizzazione. Questo è stato il mio punto di partenza: il suono della paura. In Sweet Tooth registro l’esperienza di milioni di persone. La privazione della libertà, la tortura, le punizioni, la vendita all’asta, la lavorazione della canna per produrre lo zucchero, i momenti in cui gli schiavi potevano divertirsi e cantare, momenti in cui c’era anche qualcosa di sovversivo che poteva portare alla rivolta, che era la paranoia dei proprietari di piantagioni. C’è una sezione di Sweet Tooth che si intitola Names, in cui recito i nomi dati agli schiavi, e di ciascuno il sesso, il lavoro che dovevano fare, e quanto era il loro valore: e questa parte del lavoro è così impegnativa emotivamente, da fare, ma anche da ascoltare, perché come fai a dare un valore ad una persona, un valore monetario?
Il lavoro è stato presentato in luoghi non casuali…
La prima di Sweet Tooth è stata a Liverpool al Bluecoat, un centro d’arte che era una scuola costruita con i soldi dati dai ricchi proprietari di piantagioni. A Londra Sweet Tooth è stata presentata a St George’s, a Bloomsbury, una chiesa aperta nel settecento al culmine della tratta, che ebbe tra suoi benefattori ricchi schiavisti e che poi ha avuto un ruolo nel movimento abolizionista. In maggio invece è stata proposta al Museum of London Docklands, dove veniva immagazzinato lo zucchero proveniente dai Caraibi. Sweet Tooth è un lavoro difficile da presentare, fisicamente difficile anche per i musicisti, Sylvia Hallett, Jason Yarde e Mark Sanders, che devono muoversi in scena. Per me è un lavoro non solo sulla schiavitù ma su noi oggi, perché gli esseri umani hanno una incredibile capacità di infliggere sofferenze:. Mi auguro ci spinga a porci delle domande su di noi, sul perché noi beneficiamo dello sfruttamento che avviene in altre parti del mondo.
Ascoltandola dal vivo con Alexander Hawkins era impossibile non pensare a Jeanne Lee…
Dovevo avere diciotto anni e Neil Metcalfe mi diede una cassetta dicendomi: penso che ti potrebbe piacere. Era Jeanne Lee con Ran Blake. Non è che non mi sia piaciuta ma non la capii, era chiamato jazz ma non lo era, suonava piuttosto come una cosa contemporanea, avantgarde, e la sua non era una voce così «jazz»: non era una voce brutta ma nemmeno «bella» in senso convenzionale. Una voce con un vibrato molto veloce, ma che non si estende. Non trovi in lei la normale cantante di jazz, non è Sarah Vaughan, non è Ella Fitzgerald, non è quel tipo di voce. Ma questo la rende più interessante. Ricordo di avere sentito la cassetta e poi di non averla più ascoltata per anni. Ma poi ci sono tornata. Lei amava Abbey Lincoln, c’è un suono come Abbey Lincoln, viene fuori da quella linea, ma è estremamente personale e muove la tecnica oltre, verso altre direzioni. E poi la danza, Fluxus, John Cage, la sound poetry: sono stata colpita dalla somiglianza degli interessi, non potevo credere che questa donna aveva fatto tanti anni fa queste cose che io sto cercando di fare adesso. Qualcuno ha detto che lei è la mia madre spirituale: io cerco di mantenere la mia individualità ma mi interessa questa linea. E riconosco che dentro di me è ben presente.